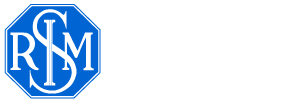- News dal Mondo Radiologico
- Bias cognitivi in radiologia diagnostica: conoscerli per ridurre gli errori
- Radiologia geriatrica: un approccio dedicato per migliorare la cura del paziente fragile
- Audit clinici in radiologia: uno strumento essenziale per qualità, sicurezza ed efficienza
- Inquinamento atmosferico e cuore: la RM cardiaca rileva la fibrosi miocardica precoce
- Glossario Radiologico con Quiz
- “Starry-sky” pattern (cielo stellato) in ecografia
.
Bias cognitivi in radiologia diagnostica: conoscerli per ridurre gli errori
Quanto incidono i bias cognitivi nella pratica radiologica quotidiana? A questa domanda risponde un recente approfondimento pubblicato su RadioGraphics, che offre una mappa dettagliata dei principali bias, esempi pratici e strategie per prevenirli.
Il contesto è quello dell’interpretazione di esami complessi in contesti ad alta intensità, come l’emergenza radiologica. Qui la pressione del tempo, l’elevato volume di studi e la varietà di patologie possono favorire scorciatoie mentali (heuristics) che, se non riconosciute, si trasformano in errori sistematici.
Il lavoro — firmato da Se-Young Yoon, Karen S. Lee e colleghi — passa in rassegna un ampio spettro di bias, dal framing bias (influenza del modo in cui l’informazione clinica è presentata) all’inattentional blindness (incapacità di notare un reperto in sedi o forme inattese), dal satisfaction of search (fermarsi dopo aver trovato la prima anomalia) all’anchoring bias (restare ancorati a un’impressione iniziale nonostante evidenze contrarie).
Interessante anche la descrizione di bias meno noti ma altrettanto pervasivi: dal bandwagon effect (propagazione acritica di diagnosi suggerite da referti precedenti) al blind obedience (accettazione senza verifica di diagnosi altrui o output di AI).
Il messaggio chiave? Essere consapevoli dei propri bias può fare la differenza. Il team propone una serie di strategie di “debiasing”, come l’uso di checklist personali, la revisione sistematica di tutte le immagini, il confronto regolare con i colleghi attraverso programmi di peer learning e l’analisi dei propri errori per imparare a riconoscere pattern ricorrenti.
Un aspetto sottolineato è l’importanza di trasformare la cultura del QA: dalle classiche conferenze sugli errori a un ambiente realmente formativo, dove chi sbaglia possa condividere apertamente i casi critici e discutere come evitarli in futuro.
In un’epoca in cui l’AI promette supporto diagnostico ma può introdurre nuovi rischi di automation bias, la riflessione di Yoon e colleghi appare particolarmente attuale. Coltivare consapevolezza metacognitiva — imparare a “pensare al proprio modo di pensare” — può aiutare il radiologo a rimanere vigile, aperto e orientato a un miglioramento continuo.
Una radiologia di precisione, sì — ma anche “mindful”: capace di riconoscere i propri limiti cognitivi per tradurre la complessità in diagnosi più accurate e sicure per i pazienti.
Per approfondire:
https://doi.org/10.1148/rg.230059 (RadioGraphics 2024; 44(7):e230059)
Radiologia geriatrica: un approccio dedicato per migliorare la cura del paziente fragile
Come affrontare in modo più efficace l’imaging diagnostico nei pazienti anziani e fragili? A questa domanda risponde un recente editoriale pubblicato su La Radiologia Medica, che lancia un vero e proprio “call to action” per sviluppare la Radiologia Geriatrica come ambito di interesse specialistico.
Il contesto è quello di una popolazione in rapido invecchiamento: entro il 2050 la quota di individui over 60 anni raddoppierà, con un conseguente aumento di pazienti fragili, spesso affetti da comorbidità multiple e ridotta resilienza agli stress clinici. Un trend che mette sotto pressione i sistemi sanitari, in particolare in ambito diagnostico.
Attualmente, manca un approccio multidisciplinare standardizzato per l’imaging di questa popolazione. Le strutture radiologiche non sempre sono attrezzate per pazienti con limitazioni motorie o cognitive, e molti professionisti non hanno una formazione specifica per riconoscere e gestire la fragilità.
Il documento evidenzia come la Radiologia possa svolgere un ruolo cruciale, non solo per la diagnosi di condizioni acute, ma anche per la prevenzione e l’individuazione precoce di alterazioni legate alla fragilità: dalla sarcopenia all’osteopenia, fino al deterioramento cognitivo. Un imaging “su misura”, con protocolli abbreviati e meno invasivi, può ridurre i rischi per i pazienti fragili e ottimizzare l’uso delle risorse.
Non meno importante è il principio del “primum non nocere”: decisioni di imaging inappropriate o troppo invasive possono compromettere la qualità di vita, senza apportare reali benefici clinici. È quindi necessario bilanciare intensità diagnostica, benessere del paziente e obiettivi assistenziali individuali.
Un ruolo chiave potrà essere giocato dall’Intelligenza Artificiale, capace di analizzare grandi moli di dati radiologici e identificare precocemente pattern di malattie croniche, integrando informazioni da altri database sanitari per una visione complessiva e predittiva.
Lo sviluppo di linee guida specifiche e di percorsi formativi dedicati alla Radiologia Geriatrica appare quindi non solo auspicabile, ma indispensabile per garantire una medicina di precisione che sia anche equa, sostenibile e centrata sulla persona fragile.
Una radiologia “amica” dell’anziano, dunque, non è un’opzione: è un passo necessario per rispondere con competenza a una delle sfide demografiche più importanti dei prossimi decenni.
Per approfondire: https://doi.org/10.1007/s11547-025-01959-3
Audit clinici in radiologia: uno strumento essenziale per qualità, sicurezza ed efficienza
Qual è il ruolo reale dell’audit clinico nella pratica radiologica moderna? A questa domanda risponde la quarta edizione della guida AUDITRAD – Esperanto dell’ESR, recentemente approvata anche dal CD SIRM, che definisce principi, modalità operative e standard di riferimento per implementare audit clinici efficaci nei dipartimenti di radiologia.
Il contesto è quello della crescente centralità del governo clinico e del rispetto delle normative europee in materia di radioprotezione (BSSD 2013/59/Euratom), che rendono l’audit non solo una buona pratica, ma un requisito legale per le procedure radiologiche che espongono a radiazioni ionizzanti. Tuttavia, nonostante l’obbligatorietà, la reale diffusione dell’audit clinico in radiologia risulta ancora disomogenea a livello europeo.
La guida AUDITRAD propone un modello strutturato, chiaro e adattabile. Si parte dal ciclo dell’audit: identificazione di un tema prioritario, definizione di standard misurabili (basati su letteratura o linee guida), raccolta ed analisi dei dati, implementazione di modifiche e re-audit per verificare i miglioramenti. Un processo ciclico che trasforma la revisione critica in miglioramento continuo.
I benefici sono concreti: l’audit riduce la variabilità clinica, migliora l’appropriatezza, ottimizza l’uso delle risorse e favorisce una radiologia sempre più “value-based”, centrata sul paziente. Non meno importante è l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, che grazie agli audit può essere monitorata in modo trasparente per garantire performance sicure, efficaci ed etiche.
Le linee guida europee sottolineano inoltre il valore di strumenti pratici come il Clinical Audit Tool dell’ESR e di iniziative coordinate come QuADRANT ed EU-JUST-CT, che promuovono approcci armonizzati tra i Paesi membri e stimolano la cultura del miglioramento.
Un audit clinico ben strutturato non è un adempimento burocratico, ma un potente alleato per la qualità e la sicurezza: contribuisce a rafforzare la fiducia di pazienti, professionisti e autorità regolatorie, evidenziando l’impegno della radiologia verso un’assistenza sempre più giustificata, ottimizzata e sostenibile.
Investire in audit significa, in definitiva, investire nella qualità della cura e nella reputazione della radiologia stessa.
Per approfondire: https://www.myesr.org/
Audit clinici in radiologia: uno strumento essenziale per qualità, sicurezza ed efficienza
Qual è il ruolo reale dell’audit clinico nella pratica radiologica moderna? A questa domanda risponde la quarta edizione della guida AUDITRAD – Esperanto dell’ESR, recentemente approvata anche dal CD SIRM, che definisce principi, modalità operative e standard di riferimento per implementare audit clinici efficaci nei dipartimenti di radiologia.
Il contesto è quello della crescente centralità del governo clinico e del rispetto delle normative europee in materia di radioprotezione (BSSD 2013/59/Euratom), che rendono l’audit non solo una buona pratica, ma un requisito legale per le procedure radiologiche che espongono a radiazioni ionizzanti. Tuttavia, nonostante l’obbligatorietà, la reale diffusione dell’audit clinico in radiologia risulta ancora disomogenea a livello europeo.
La guida AUDITRAD propone un modello strutturato, chiaro e adattabile. Si parte dal ciclo dell’audit: identificazione di un tema prioritario, definizione di standard misurabili (basati su letteratura o linee guida), raccolta ed analisi dei dati, implementazione di modifiche e re-audit per verificare i miglioramenti. Un processo ciclico che trasforma la revisione critica in miglioramento continuo.
I benefici sono concreti: l’audit riduce la variabilità clinica, migliora l’appropriatezza, ottimizza l’uso delle risorse e favorisce una radiologia sempre più “value-based”, centrata sul paziente. Non meno importante è l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale, che grazie agli audit può essere monitorata in modo trasparente per garantire performance sicure, efficaci ed etiche.
Le linee guida europee sottolineano inoltre il valore di strumenti pratici come il Clinical Audit Tool dell’ESR e di iniziative coordinate come QuADRANT ed EU-JUST-CT, che promuovono approcci armonizzati tra i Paesi membri e stimolano la cultura del miglioramento.
Un audit clinico ben strutturato non è un adempimento burocratico, ma un potente alleato per la qualità e la sicurezza: contribuisce a rafforzare la fiducia di pazienti, professionisti e autorità regolatorie, evidenziando l’impegno della radiologia verso un’assistenza sempre più giustificata, ottimizzata e sostenibile.
Investire in audit significa, in definitiva, investire nella qualità della cura e nella reputazione della radiologia stessa.
Per approfondire: https://www.myesr.org/
Inquinamento atmosferico e cuore: la RM cardiaca rileva la fibrosi miocardica precoce
Il particolato atmosferico è associato a un aumento della fibrosi diffusa anche nei soggetti sani
L’esposizione cronica all’inquinamento atmosferico può causare fibrosi miocardica? A questa domanda ha risposto uno studio pubblicato su Radiology, che ha indagato la relazione tra inquinamento da particolato fine (PM2.5) e fibrosi cardiaca diffusa mediante RM con mappatura T1, sia in pazienti con cardiomiopatia dilatativa che in controlli sani.
Il contesto è quello delle malattie cardiovascolari ambientali, oggi in crescente attenzione a causa dell’impatto del PM2.5 sulla salute pubblica. La fibrosi miocardica è un noto predittore di eventi avversi, ma i meccanismi con cui l’inquinamento contribuisce al rimodellamento ventricolare non sono completamente chiariti. La RM cardiaca, grazie al mapping T1 nativo, permette di rilevare la fibrosi diffusa in modo non invasivo e senza contrasto.
Lo studio ha incluso 694 pazienti adulti con residenza stabile da almeno un anno: 493 con cardiomiopatia dilatativa non ischemica e 201 con RM cardiaca normale. L’esposizione annuale al PM2.5 è stata calcolata sulla base del monitoraggio ambientale nel raggio di 10 km dalla residenza. La fibrosi è stata quantificata tramite T1 nativo e normalizzata come z-score, con regressione multivariata aggiustata per fattori clinici, ambientali e socioeconomici.
I risultati mostrano che ogni incremento di 1 µg/m³ di PM2.5 nell’anno precedente era associato a un aumento di 0,30 dello z-score T1 nei pazienti con cardiomiopatia dilatativa (P < .001) e di 0,27 nei controlli sani (P = .02). L’effetto era maggiore nelle donne, nei fumatori e nei pazienti ipertesi. L’associazione si manteneva anche a livelli di esposizione inferiori agli standard canadesi attualmente in vigore (8.8 µg/m³).
Lo studio propone dunque un cambiamento di paradigma nella valutazione degli effetti cardiovascolari ambientali: la mappatura T1 può rappresentare un “biomarcatore d’organo” sensibile, rilevabile precocemente anche in assenza di segni clinici o anatomici evidenti.
Questo approccio potrebbe contribuire a riconoscere precocemente i danni miocardici da esposizione cronica, integrando la prevenzione cardiovascolare con l’attenzione ai determinanti ambientali della salute. Una medicina di precisione, sì, ma anche ecologica, preventiva e proattiva.
Per approfondire:
https://doi.org/10.1148/radiol.250331
“Starry-sky” pattern (cielo stellato) in ecografia
A quale condizione si associa questo pattern?
A. Epatite acuta virale
B. Steatosi epatica non alcolica
C. Cirrosi micronodulare
D. Ascessi epatici multipli
E. Fibrosi epatica avanzata
Il termine “starry-sky pattern” (aspetto a cielo stellato) in ecografia si riferisce a un’immagine caratterizzata da:
- fondo iperecogeno o disomogeneo (spesso per un parenchima patologico)
- piccole aree iperecogene puntiformi distribuite sullo sfondo ipoecogeno, che ricordano un cielo
Quando si osserva il “starry-sky pattern” in ecografia nello studio del Fegato:
Più classicamente descritto in epatomegalia nei bambini con linfoma di Burkitt.
Anche in epatite acuta severa o sepsi, per edema del parenchima con prominenza dei dotti portali iperecogeni.