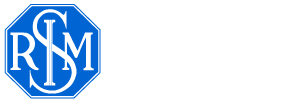GLOSSARIO RADIOLOGICO
La definizione “Honeycombing”:
Il termine “honeycombing” (aspetto a “nido d’ape”) descrive un pattern polmonare tipico di una fibrosi polmonare avanzata.
Nella TC ad alta risoluzione (HRCT), questo pattern si presenta come piccole cisti aeree multiple, di dimensioni simili, con pareti spesse, distribuite soprattutto nelle aree basali e periferiche dei polmoni.
Cosa può indicare il pattern a “nido d’ape”:
È considerato un segno di fibrosi polmonare irreversibile, spesso associato a condizioni come:
- UIP (Usual Interstitial Pneumonia) – tipica della fibrosi polmonare idiopatica (IPF)
- Malattie del tessuto connettivo (es. sclerodermia)
- Polmoniti da ipersensibilità croniche
- Asbestosi avanzata
Quiz 1
Paziente 70 aa con dispnea progressiva da mesi. HRCT mostra questo pattern Quale reperto corrisponde al “segno” più caratteristico di UIP?
- Crazy paving
- Ground-glass opacities diffuse
- Tree-in-bud
- Honeycombing
- Reversed halo

Sindrome di May-Thurner?
È una condizione anatomica e vascolare in cui:
- L’arteria iliaca comune destra schiaccia la vena iliaca comune sinistra contro la colonna vertebrale.
- Questo causa una compressione della vena, con riduzione del flusso sanguigno e predisposizione a formare trombi, specialmente nella gamba sinistra.
Sintomi principali
Spesso non si hanno sintomi, ma quando compaiono, possono includere:
- Gonfiore alla gamba sinistra
- Dolore o pesantezza alla gamba, soprattutto dopo essere stati in piedi a lungo
- Varicosità venose degli arti inferiori
- Trombosi venosa profonda (TVP) ricorrente
- Nei casi cronici: scolorimento, ulcere, o insufficienza venosa cronica
Diagnosi
La diagnosi si fa tramite:
- Ecocolordoppler
- Angio-TC o Angio-RM
- Flebografia (solo nei casi dubbi)
Trattamento
Dipende dalla gravità:
- Anticoagulanti: per prevenire o trattare la trombosi
- Angioplastica + Stent venoso: per dilatare la vena compressa
- Terapie compressive: calze elastiche
- Raramente: intervento chirurgico (nei casi refrattari)
Quiz 3
Donna 45 aa lamenta edema doloroso e congestione cutanea dell’arto inferiore sinistro. TC con mezzo di contrasto mostra questo. Qual è la diagnosi più probabile?
- Sindrome di May-Thurner
- Sindrome di Nutcracker
- Sindrome di Budd-Chiari
- Trombosi venosa profonda idiopatica
- Sindrome di Paget-Schroetter

NEWS DAL MONDO RADIOLOGICO
La Tomografia Computerizzata Dual-Energy in Italia: Uno Sguardo dalla Pratica Quotidiana
Quanto è diffusa e come viene utilizzata la Tomografia Computerizzata Dual-Energy (DECT) nella radiologia italiana? Un recente studio condotto dalla Sezione di Tomografia Computerizzata della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM) offre una panoramica dettagliata, evidenziando il potenziale ancora inespresso di questa tecnologia all’avanguardia.
La DECT nel Contesto Italiano: La DECT rappresenta una delle innovazioni più promettenti in TC, con vantaggi diagnostici che spaziano dalla riduzione della dose di radiazioni e di mezzo di contrasto alla migliore caratterizzazione dei tessuti. L’introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel quadro del Next Generation EU (NGEU) sta portando a una crescente disponibilità di questi scanner in Italia. Per comprendere la situazione attuale, tra febbraio e marzo 2022, la SIRM ha condotto un questionario anonimo coinvolgendo 261 radiologi da 90 città italiane.
Principali Rilievi dall’Indagine SIRM: Dai risultati è emerso che oltre la metà dei luoghi di lavoro dei partecipanti (51,7%) dispone già di tecnologia DECT, con un ulteriore 5% che prevede un’installazione a breve. I campi di applicazione più diffusi per la DECT sono l’imaging oncologico (70,4%) e l’angio-TC (45,2%). In ambito di emergenza, l’applicazione più comune è la diagnosi e/o l’esclusione di tromboembolia polmonare (68,1%).
Un dato significativo è che il 91,1% dei partecipanti ha dichiarato che la DECT ha migliorato la propria accuratezza diagnostica. I radiologi utilizzano la DECT principalmente per migliorare la risoluzione del contrasto (65,9%), caratterizzare i materiali (64,4%) e ridurre la quantità di mezzo di contrasto (60%).
Sfide e Prospettive Future: Il Ruolo della Formazione Nonostante i chiari benefici, lo studio ha rivelato delle lacune nella conoscenza della DECT da parte di alcuni radiologi, soprattutto tra coloro che non ne avevano uno scanner disponibile nel proprio ospedale. È stata riscontrata un’ampia variabilità nell’uso e nell’esperienza dei radiologi, indicando un vasto potenziale ancora non sfruttato.
Il messaggio chiave emerso è la necessità impellente di formazione specifica: ben il 98,1% dei partecipanti ritiene che un training mirato possa migliorare la propria conoscenza e fiducia nell’uso della DECT. Le soluzioni proposte includono corsi di formazione e aggiornamento sui principi di base, i benefici e i limiti della DECT, webinar dedicati, incontri annuali e la messa a disposizione di protocolli clinici standardizzati e ottimizzati, raccomandati da esperti.
Verso una Radiologia Sempre più Consapevole e Specializzata L’indagine SIRM sottolinea come la disponibilità degli scanner DECT stia aumentando in Italia, ma per sfruttarne appieno il potenziale è fondamentale superare le barriere legate alla conoscenza e alla standardizzazione dei protocolli. La consapevolezza di queste sfide e l’impegno nella formazione continua sono passi essenziali per garantire una radiologia di precisione, capace di tradurre l’innovazione tecnologica in diagnosi più accurate e sicure per i pazienti. Un questionario simile sarà ripetuto nel 2027 per monitorare l’evoluzione dell’uso della DECT in Italia.
Per approfondire, è possibile consultare l’articolo completo:
Gadolinio nei pazienti pediatrici: un bilancio sulla sicurezza dopo oltre 100.000 esami RM
Qual è il reale profilo di sicurezza dei mezzi di contrasto a base di gadolinio nei bambini? A questa domanda ha cercato di rispondere un’imponente meta-analisi pubblicata su Radiology, che ha analizzato oltre 112.000 esami MRI con mezzo di contrasto in ambito pediatrico.
Il lavoro, firmato da Ok Jeong Yu e colleghi, ha valutato tre aspetti cruciali: reazioni avverse (ADR), fibrosi sistemica nefrogenica (NSF) e deposito cerebrale di gadolinio.
ADR: tassi molto bassi, ma non nulli
Le reazioni acute fisiologiche si sono verificate nello 0,25% dei casi, mentre le reazioni “allergic-like” nello 0,13%. Le reazioni ritardate hanno mostrato un’incidenza ancora più bassa: 0,04%.
Interessante la distinzione tra le classi di mezzi di contrasto a base di gadolinio: gli agenti lineari sono stati associati a un rischio ADR più elevato rispetto a quelli macrociclici.
NSF: nessun caso dopo il 2007
La fibrosi sistemica nefrogenica, patologia temuta in passato, non è stata riscontrata in nessuno dei quasi 5.000 pazienti pediatrici analizzati, nemmeno nei 250 con insufficienza renale. Un dato rassicurante che riflette l’efficacia delle regolamentazioni introdotte dal 2007 in poi, in particolare sull’uso mirato dei mezzi di contrasto a basso rischio.
Deposizione cerebrale: un effetto ancora da comprendere
Se la NSF sembra ormai sotto controllo, più aperta è la questione della deposizione cerebrale di gadolinio. L’analisi ha evidenziato un’associazione significativa tra numero di somministrazioni e aumento dell’intensità di segnale nella regione dentato-ponto-cerebellare, ma solo con agenti lineari.
Questo effetto, osservato anche in bambini senza disfunzione renale, solleva interrogativi sulle possibili implicazioni a lungo termine sullo sviluppo neurologico, anche se al momento non esistono dati clinici che suggeriscano esiti negativi.
Il messaggio chiave? Rassicurazione, ma con giudizio
La conclusione degli autori è chiara: l’uso dei mezzi di contrasto a base di gadolinio nei bambini è generalmente sicuro, ma serve attenzione nella scelta del tipo di agente e nella valutazione rischio-beneficio, soprattutto in pazienti con comorbidità renali o candidati a esami ripetuti.
Anche in radiologia pediatrica, la sicurezza passa dalla consapevolezza e dalla selezione personalizzata del mezzo di contrasto.
Per approfondire:
https://doi.org/10.1148/radiol.241224 (Radiology, luglio 2025; 316(1):e241224)
L’Iniziativa SIRM: Un Faro per la Pratica Quotidiana
Per supportare i radiologi nella pratica clinica quotidiana e standardizzare l’esposizione dei pazienti, la SIRM, attraverso il suo sottocomitato specifico, ha elaborato questo position paper. L’obiettivo è fornire protocolli TC basati sull’evidenza clinica per ottimizzare gli studi e ridurre la variabilità esistente tra i diversi centri. Le linee guida coprono aree cruciali come testa e collo, encefalo e colonna vertebrale, torace e cuore.
Le Aree Chiave dei Protocolli:
- Testa e Collo: Nonostante la Risonanza Magnetica (RM) sia spesso preferita per la risoluzione dei tessuti molli, la TC rimane una tecnica di riferimento per la sua ampia disponibilità, rapidità di acquisizione (fondamentale in emergenza) e superiore visualizzazione delle strutture ossee, dei denti e dell’aria. Il documento evidenzia l’importanza della selezione del kernel e delle ricostruzioni multiplanari e 3D per definire al meglio l’anatomia e l’estensione della patologia, soprattutto in contesti di trauma o tumore .
- Encefalo e Colonna Vertebrale: La TC è ampiamente impiegata nell’imaging cerebrale, in particolare per la valutazione delle strutture ossee, delle emorragie intracraniche acute e delle calcificazioni. Per la colonna vertebrale, la TC offre una rappresentazione dettagliata delle ossa ed è cruciale per la valutazione post-operatoria, le condizioni degenerative e traumatiche. Si sottolinea l’importanza di protocolli specifici per ogni quesito clinico, ottimizzati per la dose più bassa possibile mantenendo la qualità d’immagine.
- Torace: I protocolli TC toracici, elaborati dal comitato esecutivo della Sezione Toracica della SIRM , mirano a standardizzare le tecniche per la valutazione della maggior parte delle patologie. Vengono trattati in dettaglio l’HRCT (TC ad alta risoluzione) per l’interstizio polmonare , l’angio-TC polmonare come standard per l’embolia polmonare , e la TC con mezzo di contrasto per varie indicazioni, inclusa la Dual-Energy TC. Vengono forniti suggerimenti tecnici, come l’adozione del bolus-tracking per la l’angio-TC polmonare per evitare opacizzazioni subottimali.
- Cardiovascolare: L’angio-TC coronarica (CCTA) è una delle applicazioni più complesse a causa del movimento cardiaco e delle piccole strutture da visualizzare. I protocolli devono essere ottimizzati in base alle caratteristiche del paziente (età, aritmie, frequenza cardiaca, stent) e della tecnologia dello scanner. Viene evidenziata l’importanza della velocità di rotazione del gantry, dei sistemi di modulazione automatica di kVp e mAs, e l’adeguamento dell’iniezione di contrasto. Sono fornite indicazioni precise per la gestione dei pazienti con stent coronarici, alto burden calcifico, o fibrillazione atriale, e per la pianificazione di procedure come TAVI e interventi sulla valvola mitrale.
Il Messaggio Chiave: Standardizzazione per l’Eccellenza Essere consapevoli delle variabili che influenzano l’acquisizione TC e disporre di protocolli standardizzati può fare la differenza nella pratica clinica quotidiana. Il documento SIRM non solo fornisce una base solida per l’ottimizzazione delle tecniche e la riduzione della dose, ma sottolinea anche la necessità di creare un lessico comune per superare le difficoltà legate alla mancanza di una terminologia universale tra le istituzioni.
Per approfondire:
Le Potenzialità di ChatGPT in Radiologia: Esempi Pratici
Lo studio ha testato l’utilità di ChatGPT in diverse attività radiologiche quotidiane attraverso esempi concreti. Ha dimostrato forti capacità nel:
- Strutturare i referti radiologici secondo le linee guida internazionali (ad esempio, PI-RADS per la prostata o la refertazione TC per la diverticolite). ChatGPT è in grado di organizzare il contenuto basandosi su aspetti chiave che radiologi e clinici devono valutare, incorporando linee guida riconosciute a livello internazionale (come ESGAR e ACR).
- Progettare protocolli di ricerca completi, inclusa la definizione di obiettivi, metodologia, popolazione di studio, protocolli di imaging, raccolta e analisi dei dati, considerazioni etiche, risultati attesi e limitazioni.
- Eseguire analisi statistiche avanzate da set di dati Excel, inclusa la generazione di curve ROC e il confronto tra gruppi.
- Assistere nella post-elaborazione e interpretazione delle immagini una volta convertite in formati standard (non DICOM diretti). ChatGPT può applicare algoritmi di miglioramento dell’immagine (es. CLAHE per il contrasto, Canny per il rilevamento dei bordi) per migliorare la visualizzazione di reperti sottili, fungendo da sistema di supporto decisionale.
Limiti, Sfide e Considerazioni Etiche
Nonostante le notevoli capacità, il documento evidenzia anche le limitazioni di ChatGPT. Il modello non può analizzare direttamente le immagini DICOM nell’ambiente di conversazione. Inoltre, sebbene sia in grado di strutturare i referti, sono state riscontrate occasionali
“allucinazioni” o inconsistenze nell’applicazione di punteggi complessi come il PI-RADS, mostrando che può ancora mancare della precisione degli esperti radiologi.
Gli autori sottolineano l’importanza di un’integrazione cauta di questi strumenti nei flussi di lavoro diagnostici, specialmente in classificazioni ad alto rischio. Le preoccupazioni includono la
privacy dei dati inseriti, il rischio di amplificazione dei bias presenti nei dati di addestramento e la natura di “scatola nera” di alcuni modelli di IA. Permane la necessità di una
supervisione umana critica, con i radiologi che rimangono essenziali nel flusso di lavoro diagnostico per la verifica di ogni diagnosi.
Il Messaggio Chiave: ChatGPT come Strumento di Supporto, Non Sostituzione
Il lavoro di Bellini e colleghi rafforza il concetto che l’IA generativa come ChatGPT non è destinata a sostituire il radiologo, ma a fungere da
strumento di supporto prezioso per aumentare l’efficienza operativa e migliorare vari aspetti della pratica clinica, accademica e di ricerca. La sua capacità di interagire in linguaggio naturale può anche migliorare la comunicazione tra radiologi, clinici e pazienti.
In un’epoca in cui l’IA promette un supporto diagnostico ma può introdurre anche nuovi rischi, coltivare una consapevolezza metacognitiva e un approccio critico verso questi strumenti può aiutare il radiologo a rimanere vigile, aperto al miglioramento continuo e orientato a una radiologia sempre più precisa e sicura per i pazienti.
Per approfondire: